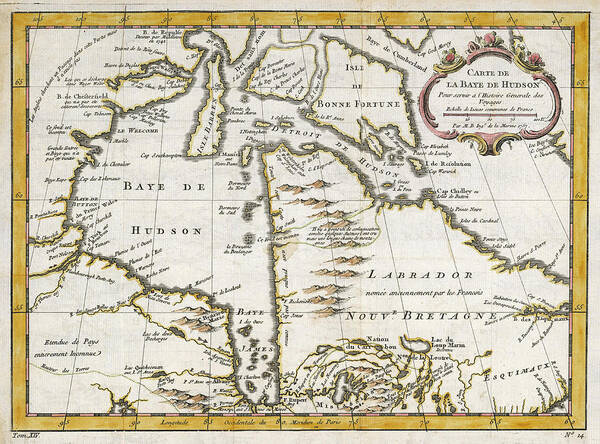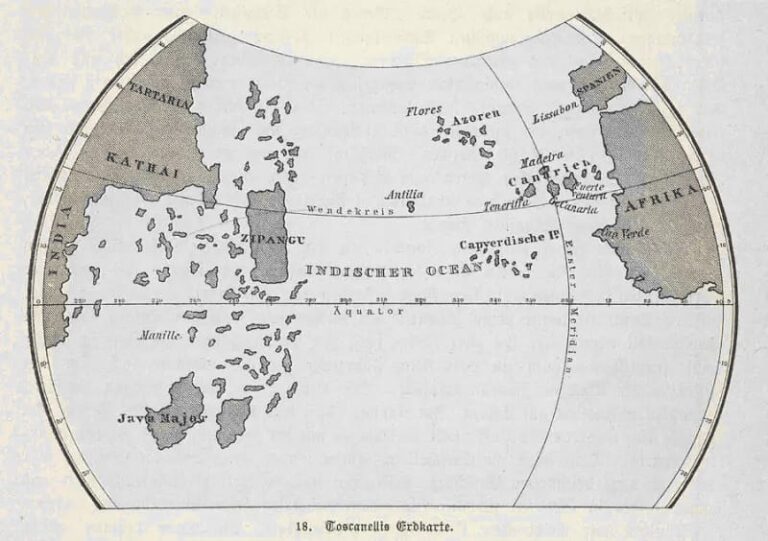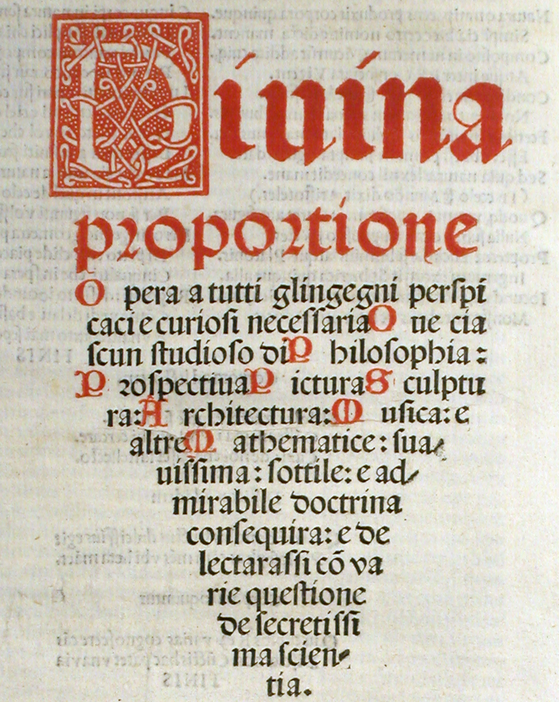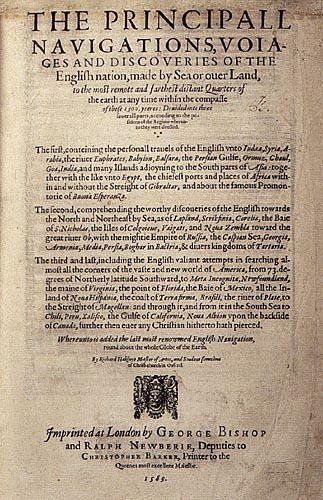Un dipinto, dopo una ricerca di anni, da pochi di mesi con importanti documenti inviati da “oltre le Alpe” può ritenersi conclusa. La traduzione da fonti tedesche è stata la conferma ad un tracciato storico sulla personalità e l’arte di Oskar Just e il suo “realismo magico onirico”.
Resta fuori il periodo Islanda e isole Färöer della vita e produzione, ritratti e paesaggi di Just, per un secondo momento della ricerca. L’unica opera giovanile, custodita a Roma, un’“Opera Salvata” e donata nel corso degli anni Ottanta, il dipinto di Just senza titolo è stato ora rinominato “Il sogno delle muse”. Il salvatore dell’opera? È stato un regista operante anche negli anni Trenta in Germania e passato a miglior vita nel 2002. In quella temperie storico-ideologica Oskar Just ci ha accompagnato attraverso due guerre e una pausa di pace armata, periodo detto anche della guerra dei Trent’anni 1914.45. Sappiamo infatti che Oskar Just “seguì un’attività molto interessante presso l’Istituto per la ricerca culturale del Prof. Hanslik: la produzione di film scientifici”. Ma, chi era Oskar Just?
Dall’atto di nascita del registro parrocchiale sappiamo che il padre di Oskar era vetraio ed il nonno calzolaio. Dal Dizionario biografico per la storia dei Länder della Boemia, pubblicato dal Collegium Carolinum da Heribert Sturm (Vol. II, lettere I-M) leggiamo: “Just Oskar, pittore, 24/03/1895 Kukan distretto di Gablonz (Kokonìn), 15/06/1964 Steyer/OӦ. Dopo la formazione a Vienna, architetto e pittore a Leitmeritz e Gablonz. Dal 1930 compie viaggi di studio all’estero in Germania e Scandinavia, pittore in Islanda e nelle isole Färöer. Residente a Hinterstoder, circondario di Kirchdorf/OӦ (Alta Austria).
La formazione e la produzione di un artista, la sua personalità manifestata attraverso l’arte fornisce spesso una testimonianza a volte dettagliata sempre molto interessante. Ripercorrere il vissuto rimasto sconosciuto consente una maggiore percezione delle grandi tensioni della vita sociale culturale e civile. Trattiamo di un artista non di un politico. La sua formazione le aspettative e le ambizioni sono essenziali, seguire i suoi viaggi, gli spostamenti di lavoro, consentono di ricostruire la trama delle relazioni esistenti tra ambiti culturali con differenze e somiglianze. Sono talvolta gli “sconosciuti” o i minori, i testimoni più sinceri del loro tempo in quanto investiti da compiti che non li impegnano a sostenere una linea politica precostituita. Si tratta di capire come mai da un contesto e un ambiente rimasto forse provinciale e chiuso, nel corso di pochi decenni della vita e produzione artistica possano venir fuori elementi significativi nel dibattito culturale, tanto da apparire personaggi non trascurabili nelle vicende della storia e delle tragedie del Novecento. I tracciati che tenevano viva una tradizione culturale, nel caso della Boemia la plurisecolare presenza di un impero, l’asburgico, nel quale dopo le guerre napoleoniche si inseriva la spinta delle nuove idee. Con Oskar Just si può parlare di una corrente locale, una tradizione specificamente attenta al paesaggio e ai caratteri dell’animo che, precedette e preparava, quei tentativi oscillanti tra un patriottismo sereno e bucolico e le spinte estreme verso un corso forzoso segnato dai nazionalismi esasperati. Indubbiamente, in Oskar Just, osserviamo l’impegno a tenere insieme un indirizzo ancestrale, pur percorrendo strade pessime e spesso intransitabili. La sua arte dai tratti bucolici e provinciali si veste di sublime sogno magico e onirico, arte rivolta al paesaggio e alla natura, risiedendo in una terra nel mezzo di due grandi imperi ai bagliori della prima guerra industrializzata e di massa innescata dall’attentato di Sarajevo del 1914. L’Europa continuava senza soluzione la corsa alla dis-armonia e al dis-amore per la vita e il vitalismo, una tragedia, una catastrofe, la morte di massa la cosiddetta guerra dei Trent’anni 1914-45, un verso unico dove precipitavano, nell’orizzonte degli eventi, anche le piccole patrie, strette e confinanti al caro vecchio blocco d’acciaio e carne da cannoni dell’intero Continente.
L’interesse principale nell’arte di Oskar Just era assicurare l’essenza di una quiete e la tranquillità delle sue rappresentazioni con ritratti di persone giovani ed anziane, con opere in prospettive paesistiche, tra figure e popolazioni, non certo partecipi allo sviluppo delle forze titaniche nefaste, totalizzanti, che demoliranno l’intero continente sotto cingoli gas e con schegge d’acciaio, nessuno escluso. Questo studio sul pittore Oskar Just sottolinea che, quand’anche il governo è il peggiore tra i totalitarismi del XX secolo, l’uomo – e l’artista, si trova impegnato in tentativi nel dare forma e bellezza, queste sì carenti nella enorme propaganda totalitaria polverizzata al vento della catastrofe, rimanendo, la sua arte, ai confini di quella patria perduta. Una esaustiva antologia sull’intera produzione di Just crediamo non si discosti dal tratto iniziale, tanto per dare un doveroso giudizio. È quanto basta esser partiti dalla sua opera giovanile, “arte salvata” e, quando sostenuta e robusta sarà la ricerca storico artistica, confidiamo che si continui, questa contribuirà non solo a dare voce al “realismo magico onirico” di Oskar Just, dai Paesi dove con i suoi viaggi ha operato, ma siamo certi che di fatto ha già lanciato un individuale contributo portatore di un germe, la pace e la serenità nei nostri Paesi e paesaggi dell’Animo.
Just è stato membro del gruppo artistico ceco-tedesco Metznerbund nel periodo post prima guerra mondiale 1920 e di certo fino al 1938. Il Metznerbund fondato a Teplice nel 1920 da artisti della Boemia di lingua tedesca, sappiamo era diviso in due associazioni ed è ben descritta nelle pagine del “Diario” di Frizt Lehmann “Prager Tagblatt”. Una rassegna d’arte a cura della Galleria d’arte regionale di Liberec nella attuale repubblica Ceca segnala che si è tenuta una conferenza su questo tema nell’ottobre 2015.
Nel contesto complesso e problematico dal 1918 al 1939 tra le due guerre, e le difficoltà importanti che hanno vissuti gli artisti in maniera differente a seconda della loro personalità, a partire dal 1933, dobbiamo tenere a mente anche la figura di Erwin Muller e la “Neue Sachlichkeit (Kunst)” La Nuova Oggettività. Un’intera generazione che il nazismo considerava Arte Degenerata che nel 1937 finiva quasi interamente al rogo, di libri e opere d’arte. Alcuni artisti dopo la catastrofe tentarono come Karl Hubbuch e Franz Radziwill di continuare la Nuova Oggettività, tanto da ridipingere quadri precedentemente perduti ma non ebbero successo. Sarà dall’America con la Pop Art e con l’apparizione di un nuovo realismo che la “Nuova Oggettività” venne riscoperta negli anni Sessanta soprattutto grazie principalmente ad un mercante d’arte italiano Emilio Bertonati (nato a Levanto 1934 – morto a Milano nel 1981). Si veda “La nuova oggettività e altre cose. Il mondo di Emilio Bertonati” è il catalogo della mostra di Lerici (Castello Monumentale luglio-settembre 2000). La mostra, dedicata a Emilio Bertonati, architetto, artista, studioso e gallerista è stata l’occasione per far conoscere attraverso le opere degli artisti più significativi il movimento tedesco della Nuova Oggettività (Neue Sachlichkeit): Otto Dix, Rudolf Schlichter, George Grosz e molti altri.
Su Arte e Politica si veda anche Enzo Collotti, “Arte e politica: la mostra dell’«arte degenerata» da Los Angeles a Berlino”, sta in «PASSATO e PRESENTE» Rivista di storia contemporanea, n. 28- gennaio/aprile 1993, pagg. 145-159.
Raffaele Panico